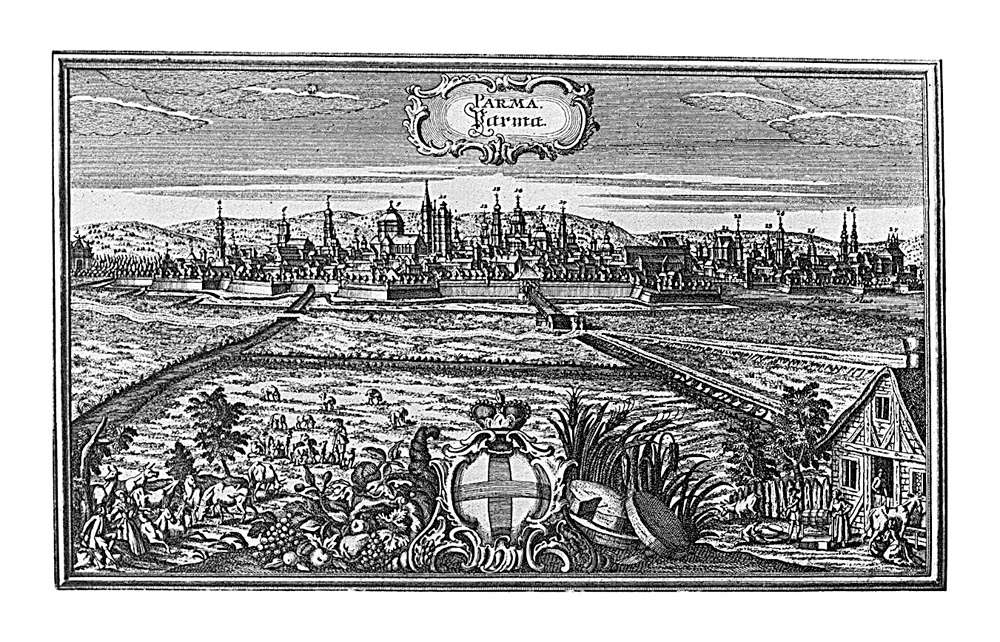Graziano Bottioni
«Il paese è fertilissimo, et frutterebbe ancor di più se molti terreni che si tengono per pastura di vacche si coltivassero»: scriveva nel 1628, a proposito delle campagne parmigiane, un inviato mediceo alle nozze di Odoardo Farnese[1].
Due secoli dopo, nel 1802, in una relazione sulle condizioni agricole del Parmense presentata al Moreau de Saint-Mery leggiamo che «l’agricoltura parmigiana si trova nel massimo avvilimento» e «concorre al suo indebolimento… il non mantenersi nel territorio quella quantità di bestiami, di cui sarebbe suscettibile» anche se «corre detto generale che anzi ne abbondiamo»[2].
I due giudizi sono antitetici. Dal primo traspare una concezione arcaica dell’agricoltura, che nell’allevamento bovino percepisce un pericoloso concorrente delle coltivazioni cerealicole destinate al sostentamento degli uomini; nel secondo prevale invece un’idea più moderna dell’agricoltura che considera i buoi «il capo più necessario di tutte le faccende dell’agricoltura»[3], idea, questa, derivante dalla penetrazione anche nel Ducato di Parma, nella seconda metà del Settecento, di quella letteratura agronomica francese e inglese che propugnava la necessità di una radicale riforma delle coltivazioni e che apriva anche nel Parmense un serrato, ma poco seguito, dibattito[4].
Viene allora naturale chiedersi quale ruolo abbia avuto in questi due secoli l’allevamento bovino nell’agricoltura parmense.
Durante i primi secoli dell’Età Moderna prevale in Emilia, e il Parmense non fa certo eccezione, la struttura poderale a base familiare, sia il conduttore proprietario, sia mezzadro, affittuario o colono. È un’agricoltura «legata a forme arcaiche, ereditate dalla più antica tradizione; la tecnica culturale è ancora prettamente intensiva, rivolta all’autoconsumo»[5]
In particolare nel Parmense si rileva un eccessivo frazionamento della proprietà, un notevole ritardo nell’introduzione dell’avvicendamento delle coltivazioni, bassi livelli di resa per le coltivazioni cerealicole e un regime contrattuale che, con l’affitto – generalmente triennale, una durata che non stimola agli investimenti e alle migliorie – e con la mezzadria – solitamente al mezzadro va da 1/3 a 1/2 del prodotto -, concorre a mantenere la condizione contadina attorno al limite della pura sussistenza dal punto di vista economico e in stato di soggezione da quello giuridico[6].
In un quadro del genere, dove è difficile la formazione autonoma di capitali e scoraggiata la loro reperibilità esterna, l’allevamento bovino ha un ruolo del tutto secondario.
Una più marcata attenzione nei suoi confronti si nota però a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo. Ne sono una sicura conferma l’introduzione della coltivazione del trifoglio e il divieto di pascolo per ovini e caprini in pianura[7]; l’apparire di numerose grida ducali volte a salvaguardare la proprietà privata a discapito del pascolo libero[8] e infine l’estendersi, almeno nelle grandi proprietà signorili, dei terreni adibiti a prato[9].
Fare una statistica esatta dei capi bovini presenti nel Parmense in questo periodo è però una cosa praticamente impossibile; da un lato per la natura generalmente fiscale delle fonti documentarie che possediamo, tanto soggette a fenomeni di sottostima, e dall’altro per la difficoltà di collocare queste fonti in un contesto territoriale omogeneo e ampio, che resti stabile nei secoli.
Due fonti territorialmente abbastanza omogenee, anche se non perfettamente coincidenti[10], sono l’estimo del 1593[11] e il «Prospetto del bestiame enumerato nel 1851»[12].
Il primo documento (1593) ci dà un totale di 33.378 bovini censiti; la statistica del 1851 ci fornisce invece una somma complessiva di 45.850 capi.
Il primo dato è probabilmente errato per difetto, mentre il secondo, più attendibile, risente di alcuni fattori, quali il ridimensionamento, in numero ed estensione, dei prati, processo avviato nei primi decenni
dell’Ottocento; le requisizioni di bestiami operate dall’esercito francese e, soprattutto, dei vuoti lasciati dalle epizooie[13], che si abbattono per tutto il Settecento – 1712, 1727, 1745, 1797, 1804 – sul Parmense, provocando un’alta mortalità tra i bovini, specialmente nel 1713, quando muore circa 1/3 del bestiame[14], e nel 1797. Le cause patologiche di queste epidemie – le più gravi furono il cancro volante e la glossantrace – sfuggivano agli uomini del tempo, come sfuggiva praticamente ai contadini la causa che aggravava gli effetti epidemici: le arretrate tecniche di allevamento.
Infatti, per quanto molti agronomi settecenteschi consigliassero di avere molte attenzioni per il bestiame, curandone i pascoli, tenendolo in stalle pulite, addirittura profumate «con odori di ginepro, olio, salvia, metico», e ben arieggiate, offrendogli una buona alimentazione a base di «fava, vezza, con una porzione di semola e fieno mazengo buono»[15], la realtà era invece molto diversa.
Leggiamo, in due relazioni del periodo francese, che le «vacche del Parmigiano sono generalmente poco curate, e sono quelle che mangiano peggio» avendo anche i «pascoli peggiori»[16; le stalle sono poi in pessime condizioni «bassissime» tanto che «un uomo di mediocre statura appena vi può stare in piedi», senza finestre ma solo con «spiragli avanti la mangiatoia» tenuti però dai contadini ermeticamente chiusi perché d’inverno la stalla diventava il centro della vita collettiva[17].
Non esisteva alcuna misura di prevenzione e generalmente inefficaci erano gli interventi terapeutici.
Scarsi risultati otteneva anche la legislazione in materia di epidemie, che prevedeva l’isolamento delle stalle, la sospensione dei commerci, la chiusura dei mercati, il seppellimento degli animali morti in luoghi appositi cosparsi di calce, il divieto per i contadini di abbandonare i luoghi dove risiedevano per trasferirsi altrove e, nei casi più gravi, l’isolamento di interi paesi![19].
La mortalità era comunque molto alta, tanto che nell’epizooia del 1745-1747 le bestie bovine «morirono quasi tutte»[19]. Tornando alle statistiche, scorrendo l’estimo del 1593 e il censimento del 1851, si ha l’impressione che il patrimonio zootecnico esistente fosse insufficiente ai bisogni dell’agricoltura parmense; impressione che si fa certezza nel commento al «Prospetto» del 1851, là dove è detto che «il nostro bestiame non è sufficiente a produrre tanto letame quanto la buona agricoltura moderna richiederebbe che se ne somministrasse ai terreni coltivati e ai prati stabili», prati che «sono ancora poco estesi» e dove «il nome di trifoglio suona come quello di una malerba nelle orecchie di molti contadini»[20]
Argomenti analoghi compaiono anche nella relazione del 1802 in cui si sostiene che «noi manchiamo di letami, non essendovi possessione che faccia letame che basti a letamare a dovere la sesta parte». Ciò deprimeva fortemente le produzioni agricole perché «nei lavori anche i più gravosi noi regolarmente non aggioghiamo al nostro aratro che due sole paia di bestie quando i circonvicini mai meno di tre», perciò «i nostri lavori di campagna sono mal fatti generalmente… oltre l’essere anche tardivi; e la scarsezza dei nostri raccolti prova questa proposizione come prova che siamo scarsi di letami: se all’opposto avessimo la decantata abbondanza di bestiami, avessimo maggiori e meglio fatti i lavori, avessimo maggior letame ed in conseguenza maggiori i prodotti»[21].
Entrambi i censimenti riportano un numero quasi uguale di buoi e vacche. Scarsa è la quantità di vitelli. I tori sono 1.212 (2,6%) nel censimento del 1851 e non vengono indicati in quello del 1593.
Ciò è significativo di una tendenza dell’agricoltura parmense a importare vitelli da ingrasso e a esportare bestie da macello[22]; fatto che è ben dimostrato, più che dalle cifre ufficiali dei capi venduti, peraltro largamente in difetto essendo di natura fiscale, dall’ossessivo ripetersi delle grida ducali che proibiscono l’estrazione non autorizzata di bestiami, onde contenere il contrabbando di bovini fuori dai confini dello Stato. Proclami in sostanza inefficaci, perché ancora nel 1794 si rileva che «molto bestiame si vede uscire dallo stato clandestinamente»[23], e tuttavia indicativi dell’importanza assunta da questo commercio clandestino.
L’alto numero di buoi fa supporre che l’allevamento fosse finalizzato molto più alla disponibilità di forza lavoro per i campi, piuttosto che alla produzione e commercializzazione dei derivati del latte, tanto che «di formaggi, butirri… ci provvede il Reggiano ed il Lodigiano ed altri», si osservava ai primi dell’Ottocento[24].
L’importazione di formaggi è un fatto tanto diffuso da costringere il governo a imporre, a metà del Settecento, una forte tassa sulla importazione di prodotti caseari»[25], e in grado di determinare nel corso dello stesso secolo una grave crisi del caseificio parmense[26].
Guardando l’estimo del 1593 vediamo come la maggiore concentrazione di bovini si abbia nella Bassa e nelle ville che gravitano intorno alla foce dell’Enza, campagne dove c’è anche il più alto numero di vacche. A questo quadro fa eccezione Noceto per ragioni che diremo più avanti.
La stragrande maggioranza dei censiti possiede meno di cinque capi bovini. Il dato si spiega col fatto che la proprietà fondiaria è molto frazionata, tanto che le unità poderali che non superano le tre biolche sono percentualmente le più numerose[27].
Tale frazionamento, che caratterizzò in larga misura la struttura della proprietà fondiaria nel Parmense sino all’Ottocento, era quanto meno inadatta all’allevamento bovino che, secondo gli agronomi del tempo, pretendeva tre biolche di prato per ogni bestia grossa allevata[28], e limitava fortemente la possibilità di una ripartizione integrata dell’azienda agricola tra il coltivato e il prativo, sacrificando così l’allevamento a quelle colture indispensabili, sebbene non sempre sufficienti, al sostentamento della famiglia contadina, soprattutto in una situazione sociale dove la figura del piccolo proprietario era percentualmente predominante[28]. E solo nelle grandi proprietà fondiarie della nobiltà che troviamo numerose «vaccherie» e una tale concentrazione di bovini da far pensare ad aziende specializzate nell’allevamento e nella produzione di latticini e carne. Tale, per esempio, è il caso dei Rossi e dei Sanvitale.
I Rossi tengono 1’80% delle terre che hanno a San Secondo a pascolo. Le terre sono affidate a fittavoli e mezzadri che nel 1593 dispongono complessivamente di 469 capi bovini. Analogo il caso dei Sanvitale, signori di Noceto, dove riscontriamo la più alta concentrazione (4,5%) di bovini di tutto il Parmense: 1511 capi.
A questo punto, assodata l’insufficienza del patrimonio bovino nel Parmense, è chiaro che il problema dell’allevamento bovino va ricondotto nel più ampio contesto dell’assetto strutturale della proprietà fondiaria. Da un lato poche grandi proprietà fondiarie articolano in maniera equilibrata la superficie coltivabile tra colture e allevamento, avendo come scopo non tanto quello di produrre solo per l’autoconsumo ma anche per il mercato, potendo pertanto razionalizzare in forme specifiche – la vaccheria – l’allevamento bovino. Queste aziende, organizzate secondo il modello lombardo, sono però rare. Tutto intorno c’è il pulviscolo delle piccole aziende deputate alla produzione per l’autoconsumo famigliare, con raccolti spesso insufficienti, e che sopravvivono a fatica. Qui il bovino può essere un concorrente, una bocca in più, nella distribuzione in razioni degli scarsi prodotti del suolo; ma è anche utile per potere concimare il terreno e di aiuto per i lavori agricoli. A volte, il bovino diventa però anche un indispensabile integratore nei bilanci della piccola azienda perché col suo latte si può organizzare una piccola produzione domestica di burro, ricotta e formaggio e, quando muore, se ne può vendere la carne e la pelle. E quest’ultima doveva essere una pratica abbastanza diffusa se le grida ducali s’incaricano di vietarla, minacciando chi la esercitava di forti ammende. La piccola proprietà, proprio per le sue caratteristiche strutturali, intrattiene però col mercato rapporti sporadici e frammentari; le mancano infatti spazi e capitali per impostare un allevamento secondo l’ottica economica della ricerca del profitto. A questo uso promiscuo (lavoro-latte-carne) la vacca di razza parmigiana si prestava molto bene. Aveva «membra quadrate muscolose e forti. Il suo pelame era di un rosso infuocato, con spesso bianco il disotto del ventre, le internatiche e il fiocco della coda». I buoi avevano un peso medio di 3,5 quintali e all’ingrasso potevano arrivare a cinque. Si trattava di animali resistenti e adatti al lavoro. Fornivano una buona carne e le vacche producevano latte «quanto le forestiere» che si era incominciato a introdurre nel Parmense, soprattutto dal Reggiano, verso la fine del XVIII secolo, nonostante che molti raccomandassero «si preferisca la vacca nostrana alla forestiera»[29].
Sulle montagne «prevaleva quella razza podalica a pelo biancogrigiastro, che vuolsi proveniente dalle steppe del Volga ed importata nel VII secolo, durante le irruzioni dei Barbari in Romagna, da dove si stese … su tutto l’Appennino». Aveva «forme tozze e massiccie», il collo grosso, un torace ampio e «l’unghia salda e robusta rendevola resistente alle più aspre fatiche e ai viaggi disagevoli delle vie montane»[30]. Questa era però soprattutto una razza da lavoro perché aveva «una limitatissima attitudine alla produzione del latte, e molto limitata quella per la produzione della carne»[31].
Le informazioni dirette e indirette di cui si dispone consentono dunque di affermare che durante l’Età Moderna il patrimonio bovino era largamente insufficiente ai bisogni della agricoltura parmense. Una agricoltura del resto arretrata, per la maggior parte votata a produzioni destinate all’autoconsumo, caratterizzata da un regime della proprietà improntata alla polverizzazione fondiaria che tagliava irrimediabilmente fuori da ogni possibile razionalizzazione dell’allevamento una larga parte di contadini e, per di più, con un regime contrattuale che favoriva l’inerzia e l’asservimento dei coloni.
Di questa precaria situazione molti osservatori colti si rendevano conto, ma restavano generalmente inascoltati perché le strutture economiche, sociali e giuridiche del ducato favorivano la conservazione dell’esistente piuttosto che la ricerca del nuovo.
La situazione perdurerà sostanzialmente immutata sin dopo l’Unità, quando anche nel Parmense l’avvento graduale di un’ottica di capitalismo agrario permetterà all’allevamento bovino, attraverso la massiccia introduzione di altre razze bovine, di divenire fattore propulsivo della industria casearia moderna, col tempo divenuta uno dei cardini dell’economia agro-industriale parmense.
Il saggio è tratto da Terre e buoi. Il patrimonio bovino nel Parmense dall’Ottocento a oggi. Catalogo della mostra: Parma, Sala Ulivi, 28 settembre-3novembre 1985 organizzata da Provincia di Parma, Assessorato Agricoltura Alimentazione e Foreste e qui riproposto su autorizzazione della Provincia di Parma rilasciata il 10.01.2025.
[1] Appunti sullo Stato di Parma, in «Rassegna Nazionale», XXIII, p. 34.
[2] ASPR, Moreau de Saint Mery, Agricoltura, b 17, fasc. III. D’ora in avanti questo documento sarà citato come Relazione 1802.
[3] V. Melegari, Osservazioni ed avvertimenti d’agricoltura pratica, Parma 1817, p. 98.
[4] Alcuni dei testi d’agricoltura più importanti di questo periodo sono: Insegnamenti di agricoltura parmigiana del XVIII secolo, a cura di P.L. Spaggiari, Parma 1964 (È la pubblicazione di un manoscritto settecentesco di autore anonimo. Cfr. ASPR, Raccolta manoscritti, n. 138); F. Re, Elementi di agricoltura, Parma 1798; V. Melegari, Osservazioni… cit.; nel 1803 appariva il «Giornale economico agrario» e nel 1805 veniva fondata un’accademia di agricoltura: la «Società Economica Agraria».
[5] A. Anedda, L’agricoltura in Emilia tra XVIII e XIX secolo, in Agricoltura e aziende agrarie nell’Italia centro-settentrionale, a cura di G. Coppola, Milano 1983, p. 201.
[6] Cfr. Relazione 1802, cit. Sull’agricoltura parmense cfr. C. Rognoni, Sull’antica agricoltura parmense, Parma 1897; P.L. Spaggiari, L’agricoltura negli stati parmensi dal 1750 al 1859, Milano 1866.
[7] ASPR, Gridari, vol. 10, «Decreto sopra li danni dati et mezadrie del dominio e territorio parmigiano…» S.N.T. 1576; cfr., anche il vol. 50, decreto n. 81, 17 maggio 1687.
[8] ASPR, Gridari, vol. 18 e 30, passim.
[9] Cfr. M.T. Bobbioni, Aspetti del paesaggio agrario e della proprietà terriera nel ducato di Parma tra ’500 e ’600: San Secondo Parmense, in «Rivista di storia dell’agricoltura» XX, 1980, PP 107-124; L. Arcangeli, Una grande proprietà nella pianura parmense. La formazione delle «possessioni prative» dei Sanvitale di Fontanellato nel sec. XVI, in Agricoltura e aziende … cit., pp. 157-194.
[10] Riguardano lo stato parmense senza Borgo San Donnino e la Val Taro.
[11] ASPR, Catasti, bb. 1041-1042.
[12] Supplemento alla «Gazzetta di Parma», n. 144, del giorno 30 giugno 1852.
[13] Cfr. P.L. Spaggiari, L’agricoltura negli stati parmensi… cit., pp. 48-48.
[14] ASPR, Santità pubblica, b. 8.
[15] Insegnamenti di agricoltura…cit., pp. 136-135.
[16] ASPR, Moreau de Saint Mery, Agricoltura, b. 17, fasc. XV, s.d.t.
[17] ASPR, Moreau de Saint Mery, Agricoltura, b. 17, fasc. II, 2 gennaio 1801.
[18] Una ricca documentazione in materia, soprattutto per l’epidemia del 1712-1713, c’è fornita dai Gridari dell’Archivio di Stato di Parma. Cfr. in particolare i volumi 58, 59, 60, 118, 119, 120.
[19] Insegnamenti di agricoltura… cit., p. 273.
[20] Supplemento … cit.
[21] Relazione 1802, cit.
[22] Ibidem
[23] ASPR, Moreau de Saint Mery, Agricoltura, b. 17, fasc. XX, «Estrazione di bestiami nel corso di un novennio», 1794.
[24] Relazione 1802, cit.
[25] ASPR, Gridari, vol. 76. «Grida sopra il bollo de formaggi forastieri», 16 giugno 1751.
[26] Cfr. C. Rognoni, Sull’antica agricoltura… cit., p. 36.
[27] Cfr. M.T. Bobbioni, Aspetti del paesaggio agrario, cit.
[28] Cfr. Insegnamenti di agricoltura … cit., p. 138.
[29] Cfr. M.T. Bobbioni, Aspetti dell’economia agricola parmense nel secolo XVII, in «Rivista di storia dell’agricoltura», XVI, 1976, pp. 119-149.
[30] V. Melegari, Osservazioni ed avvertimenti … cit., p. 104; C. Rognoni, Sull’antica agricoltura… cit., p. 54.
[31] C. Rognoni, Sull’antica agricoltura … cit., pp. 54-55.
[32] G. Nuvoletti, A proposito del miglioramento del bestiame nell’Appennino parmense, in «L’Avvenire agricolo», 1894, pp. 188-189.